.jpg)
Viva la storia di Molfetta!
Dentro la Pasqua di Molfetta: viaggio tra fede, riti e leggende
La Quaresima diventa una vera e propria sospensione del tempo profano
martedì 15 aprile 2025
Nel cuore della Terra di Bari, Molfetta custodisce una delle più affascinanti e complesse tradizioni pasquali del Sud Italia. Non si tratta solo di processioni e statue, ma di una stratificazione di riti, credenze e strategie religiose che affondano le radici nel XVI secolo e si sviluppano lungo tutto l'arco della modernità. Comprendere la Pasqua a Molfetta significa compiere un viaggio nel tempo, tra magia e fede, tra controllo sociale e resistenza culturale.
Fin dai primi secoli del Cristianesimo, la Quaresima fu concepita come tempo di penitenza, purificazione e rinuncia. A partire dal VII secolo, si diffuse la prescrizione di consumare un solo pasto al giorno, nel pomeriggio, e di astenersi da carne, uova, latte, vino e rapporti coniugali. Nel Regno di Napoli, queste norme venivano vissute con una particolare intensità: non solo per la forza della predicazione ecclesiastica, ma per il profondo radicamento della religiosità nella vita quotidiana. A Molfetta, come nel resto della Terra di Bari, la Quaresima divenne una vera e propria sospensione del tempo profano: un periodo in cui si doveva "morire a sé stessi" per rinascere nella Pasqua.
Nel contesto della riforma cattolica post-tridentina, la città di Molfetta rappresenta un caso emblematico di scontro – e compromesso – tra religiosità ufficiale e pratiche popolari. Particolarmente significativa è la testimonianza relativa al rito di guarigione dei bambini epilettici, celebrato il 25 marzo presso la Basilica della Madonna dei Martiri. In quell'occasione, i rami dei fichi venivano tagliati e fasciati assieme ai bambini, mentre il sacerdote recitava brani evangelici. Sebbene tale rito fosse osteggiato dal vescovo locale, la sua estirpazione risultò impossibile: la popolazione lo trasferì temporaneamente in chiese vicine o rurali. Alla fine, la Chiesa optò per un compromesso, confinando il rito alla sola giornata dell'Annunciazione e subito dopo la funzione religiosa.
Questo esempio dimostra quanto la devozione popolare fosse resistente alle imposizioni dell'ortodossia tridentina. Molfetta, infatti, era inserita in un territorio – quello della Terra di Bari – dove le pratiche curative, i riti sincretici e le credenze magico-religiose sopravvivevano con forza. Le visite pastorali del tempo documentano l'uso di ossa, grassi, filtri e formule magiche per curare mali fisici e affettivi. Questi elementi fanno emergere una religiosità bifronte: da un lato la dottrina ufficiale della Chiesa; dall'altro una "contro-religione" popolare, alimentata da bisogni concreti e speranze arcaiche.
Nel 1611, con la fondazione del collegio gesuitico di Molfetta, la città entrò pienamente nel progetto controriformista della Compagnia di Gesù. I Gesuiti si distinsero per l'uso di strumenti spettacolari di evangelizzazione: missioni popolari, processioni con crocifissi, immagini viventi, e prediche dal tono drammatico. Lo scopo non era solo teologico, ma profondamente pedagogico: educare la popolazione attraverso l'impatto visivo e l'emozione.
Durante le missioni, si organizzavano vere e proprie rappresentazioni sceniche della Passione: processioni itineranti, immagini della flagellazione, del Cristo coronato di spine, e del Calvario. L'efficacia delle missioni gesuitiche fu tale che esse contribuirono alla nascita o alla riformulazione delle confraternite laicali, che sarebbero divenute le protagoniste delle celebrazioni pasquali.
Le prime tracce documentate di confraternite a Molfetta risalgono al 1570, anno in cui la Confraternita di Santo Stefano diede vita alla celebre "Processione dei Misteri". A quel tempo, le statue lignee raffiguranti i momenti salienti della Passione vennero scolpite, probabilmente in area napoletana. Nel 1709, un editto vescovile autorizzò ufficialmente ogni confraternita a possedere e portare in processione la propria statua. Fu un momento cruciale: le confraternite divennero centri di organizzazione religiosa, ma anche di rappresentazione sociale.
Particolarmente significativa è la Confraternita della Morte, fondata nel 1613. Aggregata alla prestigiosa Arciconfraternita di Roma, essa offriva sepoltura gratuita agli indigenti e prendeva parte attiva alla Settimana Santa, trasportando la statua della Pietà. Questa figura – la Vergine che tiene in grembo il corpo del Cristo morto – diventò l'icona per eccellenza del Venerdì Santo molfettese. Le confraternite si distinguevano per composizione sociale (alcune popolari, altre di élite), e riflettevano le dinamiche comunitarie e le tensioni sociali della città.
Un altro elemento chiave del patrimonio pasquale molfettese è la devozione alla Mater Dolorosa. La figura della Vergine Addolorata, con il cuore trafitto da spade, ha radici nella rielaborazione cristiana del pianto rituale pagano. Se nei Vangeli Maria non viene rappresentata piangente, nel culto popolare – specialmente nel Mezzogiorno – essa diventa l'incarnazione del dolore redentivo. Le prefiche, bandite nei sinodi pugliesi tra Cinquecento e Seicento, sopravvivono nella postura e nell'iconografia della Madonna vestita di nero, silenziosa, afflitta.
Nel caso di Molfetta, la processione dell'Addolorata e quella della Pietà traducono in linguaggio visivo una complessa teologia del pathos: il dolore non come debolezza, ma come partecipazione alla salvezza. Questo sincretismo tra pianto rituale e dogma cattolico è uno dei tratti distintivi della Settimana Santa meridionale, e trova a Molfetta una delle sue espressioni più raffinate e antiche.
La Settimana Santa a Molfetta non è solo una tradizione: è un palinsesto storico, un corpo vivo di simboli, memoria e tensioni. Le processioni, con i loro ritmi solenni e i loro codici silenziosi, sono il frutto di secoli di negoziazione tra autorità ecclesiastica e fede popolare, tra spettacolo sacro e bisogno di salvezza. A Molfetta, la Pasqua non si limita a essere celebrata: si attraversa, si mette in scena, si tramanda. E in questo lento camminare collettivo dietro le statue, la città rinnova ogni anno il suo legame più profondo con la storia e con il sacro.
Bibliografia essenziale
Corrado Innominato, Cultura popolare e Settimana Santa a Molfetta (Sec. XVI–XVIII). Origini e tradizione, disponibile su Academia.edu.
G. Ciappelli, Carnevale e Quaresima. Comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997.
E. De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
E. De Martino, Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 2001.
F. Di Palo, Stabat Mater Dolorosa. La Settimana Santa in Puglia: ritualità drammatica e penitenziale, Fasano, Schena, 1992.
L. M. de Palma, Forme associative di vita cristiana in età moderna nella diocesi di Molfetta, in Le Confraternite pugliesi in età moderna, Fasano, Schena, 1998.
G. de Marco, Dalle ceneri alla Settimana Santa, Molfetta, Mezzina, 1987.
S. Palese, Pratiche magiche e religiosità popolare in Terra di Bari durante l'età moderna, Bari, F.lli Zonno, 1978.
P. Burke, Cultura popolare nell'Europa moderna, Milano, Mondadori, 1980.
Fin dai primi secoli del Cristianesimo, la Quaresima fu concepita come tempo di penitenza, purificazione e rinuncia. A partire dal VII secolo, si diffuse la prescrizione di consumare un solo pasto al giorno, nel pomeriggio, e di astenersi da carne, uova, latte, vino e rapporti coniugali. Nel Regno di Napoli, queste norme venivano vissute con una particolare intensità: non solo per la forza della predicazione ecclesiastica, ma per il profondo radicamento della religiosità nella vita quotidiana. A Molfetta, come nel resto della Terra di Bari, la Quaresima divenne una vera e propria sospensione del tempo profano: un periodo in cui si doveva "morire a sé stessi" per rinascere nella Pasqua.
Nel contesto della riforma cattolica post-tridentina, la città di Molfetta rappresenta un caso emblematico di scontro – e compromesso – tra religiosità ufficiale e pratiche popolari. Particolarmente significativa è la testimonianza relativa al rito di guarigione dei bambini epilettici, celebrato il 25 marzo presso la Basilica della Madonna dei Martiri. In quell'occasione, i rami dei fichi venivano tagliati e fasciati assieme ai bambini, mentre il sacerdote recitava brani evangelici. Sebbene tale rito fosse osteggiato dal vescovo locale, la sua estirpazione risultò impossibile: la popolazione lo trasferì temporaneamente in chiese vicine o rurali. Alla fine, la Chiesa optò per un compromesso, confinando il rito alla sola giornata dell'Annunciazione e subito dopo la funzione religiosa.
Questo esempio dimostra quanto la devozione popolare fosse resistente alle imposizioni dell'ortodossia tridentina. Molfetta, infatti, era inserita in un territorio – quello della Terra di Bari – dove le pratiche curative, i riti sincretici e le credenze magico-religiose sopravvivevano con forza. Le visite pastorali del tempo documentano l'uso di ossa, grassi, filtri e formule magiche per curare mali fisici e affettivi. Questi elementi fanno emergere una religiosità bifronte: da un lato la dottrina ufficiale della Chiesa; dall'altro una "contro-religione" popolare, alimentata da bisogni concreti e speranze arcaiche.
Nel 1611, con la fondazione del collegio gesuitico di Molfetta, la città entrò pienamente nel progetto controriformista della Compagnia di Gesù. I Gesuiti si distinsero per l'uso di strumenti spettacolari di evangelizzazione: missioni popolari, processioni con crocifissi, immagini viventi, e prediche dal tono drammatico. Lo scopo non era solo teologico, ma profondamente pedagogico: educare la popolazione attraverso l'impatto visivo e l'emozione.
Durante le missioni, si organizzavano vere e proprie rappresentazioni sceniche della Passione: processioni itineranti, immagini della flagellazione, del Cristo coronato di spine, e del Calvario. L'efficacia delle missioni gesuitiche fu tale che esse contribuirono alla nascita o alla riformulazione delle confraternite laicali, che sarebbero divenute le protagoniste delle celebrazioni pasquali.
Le prime tracce documentate di confraternite a Molfetta risalgono al 1570, anno in cui la Confraternita di Santo Stefano diede vita alla celebre "Processione dei Misteri". A quel tempo, le statue lignee raffiguranti i momenti salienti della Passione vennero scolpite, probabilmente in area napoletana. Nel 1709, un editto vescovile autorizzò ufficialmente ogni confraternita a possedere e portare in processione la propria statua. Fu un momento cruciale: le confraternite divennero centri di organizzazione religiosa, ma anche di rappresentazione sociale.
Particolarmente significativa è la Confraternita della Morte, fondata nel 1613. Aggregata alla prestigiosa Arciconfraternita di Roma, essa offriva sepoltura gratuita agli indigenti e prendeva parte attiva alla Settimana Santa, trasportando la statua della Pietà. Questa figura – la Vergine che tiene in grembo il corpo del Cristo morto – diventò l'icona per eccellenza del Venerdì Santo molfettese. Le confraternite si distinguevano per composizione sociale (alcune popolari, altre di élite), e riflettevano le dinamiche comunitarie e le tensioni sociali della città.
Un altro elemento chiave del patrimonio pasquale molfettese è la devozione alla Mater Dolorosa. La figura della Vergine Addolorata, con il cuore trafitto da spade, ha radici nella rielaborazione cristiana del pianto rituale pagano. Se nei Vangeli Maria non viene rappresentata piangente, nel culto popolare – specialmente nel Mezzogiorno – essa diventa l'incarnazione del dolore redentivo. Le prefiche, bandite nei sinodi pugliesi tra Cinquecento e Seicento, sopravvivono nella postura e nell'iconografia della Madonna vestita di nero, silenziosa, afflitta.
Nel caso di Molfetta, la processione dell'Addolorata e quella della Pietà traducono in linguaggio visivo una complessa teologia del pathos: il dolore non come debolezza, ma come partecipazione alla salvezza. Questo sincretismo tra pianto rituale e dogma cattolico è uno dei tratti distintivi della Settimana Santa meridionale, e trova a Molfetta una delle sue espressioni più raffinate e antiche.
La Settimana Santa a Molfetta non è solo una tradizione: è un palinsesto storico, un corpo vivo di simboli, memoria e tensioni. Le processioni, con i loro ritmi solenni e i loro codici silenziosi, sono il frutto di secoli di negoziazione tra autorità ecclesiastica e fede popolare, tra spettacolo sacro e bisogno di salvezza. A Molfetta, la Pasqua non si limita a essere celebrata: si attraversa, si mette in scena, si tramanda. E in questo lento camminare collettivo dietro le statue, la città rinnova ogni anno il suo legame più profondo con la storia e con il sacro.
Bibliografia essenziale
Corrado Innominato, Cultura popolare e Settimana Santa a Molfetta (Sec. XVI–XVIII). Origini e tradizione, disponibile su Academia.edu.
G. Ciappelli, Carnevale e Quaresima. Comportamenti sociali e cultura a Firenze nel Rinascimento, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1997.
E. De Martino, Morte e pianto rituale nel mondo antico, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.
E. De Martino, Sud e magia, Milano, Feltrinelli, 2001.
F. Di Palo, Stabat Mater Dolorosa. La Settimana Santa in Puglia: ritualità drammatica e penitenziale, Fasano, Schena, 1992.
L. M. de Palma, Forme associative di vita cristiana in età moderna nella diocesi di Molfetta, in Le Confraternite pugliesi in età moderna, Fasano, Schena, 1998.
G. de Marco, Dalle ceneri alla Settimana Santa, Molfetta, Mezzina, 1987.
S. Palese, Pratiche magiche e religiosità popolare in Terra di Bari durante l'età moderna, Bari, F.lli Zonno, 1978.
P. Burke, Cultura popolare nell'Europa moderna, Milano, Mondadori, 1980.




.jpg)
_(1).jpg)

.jpg)

.jpg)

 Ricevi aggiornamenti e contenuti da Molfetta
Ricevi aggiornamenti e contenuti da Molfetta 


.jpg)

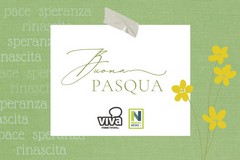



.jpg)





